Armando, com’è iniziato tutto? Se non sbaglio andasti in Inghilterra nel 1966.
Sì. Era l’11 giugno 1966, un sabato. Avevo finito il servizio militare in Italia il 10 marzo e passai i tre mesi successivi a scrivere a ditte che si occupavano di ingegneria in Inghilterra, perché volevo trasferirmi là con un biglietto di sola andata. A Roma lavoravo per una ditta americana che si occupava di sviluppare nuove città in Libia, un lavoro che avevo iniziato prima del servizio militare. Prima ancora avevo lavorato come geometra per SDD, la ditta italiana che stava costruendo l’autostrada tra Messina e Catania. Quando ero all’SDD presi il diploma di geometra studiando alll’Istituto Fevola, la sera, con ottimi insegnanti. In due anni presi un diploma che normalmente ne richiedeva cinque, e così facendo mi misi alla pari con i miei amici adolescenti che avevano passato gli ultimi anni andando a scuola e stufandosi. Scrissi ad almeno trenta ditte londinesi rispondendo ai loro annunci sul London Times che trovavo al giornalaio di Via Veneto, proprio di fronte all’Hotel Excelsior e a un tiro di schioppo dall’Ambasciata Americana. Era fantastico, perché tutti rispondevano e una decina dissero: “quando vieni in Inghilterra, passa a trovarci.”
All’inizio di maggio fui molto fortunato perché John Lewis, della Chamberlain Parking Systems of London, venne a Roma e mi chiese di incontrarlo in Via Veneto. Era un ingegnere e direttore di progetto, e parliamo di sistemi di parcheggio nel 1966.Tre anni prima Fellini aveva girato “8 1/2” e la prima scena è un ingorgo stradale, ma non c’erano ingorghi nel 1963, era davvero avanti anche solo pensarci. Lewis mi disse che Chamberlain stava pensando di espandersi in Europa e che sarebbe stato interessato ad assumere un geometra italiano. Quindi mi trasferii a Londra… fu una sorpresa per la mia ragazza, perché arrivai il giorno del suo compleanno. Si chiamava Gail Simpson, e quindi… finii dai Simpson! (Ride) E questo prima ancora che i Simpson esistessero. Ci crederesti?
Il lunedì mattina mi recai da Chamberlain Parking Systems, molto vicino a Victoria Station, per parlare con Mr. Lewis, e prima che mi rendessi conto di cosa stesse accadendo avevo un lavoro. Alle 11 di mattina un ingegnere scozzese il cui nome era Mr. Fairgrieves mi diede alcuni schizzi e delle note. Aveva un accento molto forte e non riuscivo a capire una parola di ciò che diceva, ma fu molto gentile e tirò fuori una foto dal suo portafoglio: me la mostrò indicando un giovane soldato fiero e di bell’aspetto in piedi presso la fontana di Piazza Esedra a Roma, alla fine della guerra, a fianco di una splendida ragazza. “Si chiamava Maria!”, mi disse, ed era chiaro che la foto risalisse alla fine della guerra, come era chiaro che lui avesse lasciato a Roma un pezzo del suo cuore. Lavorai con lui tutta l’estate e alla fine cercarono di farmi avere un permesso di lavoro. Fammici pensare… Beh, Jimi Hendrix venne a Londra nel mese di settembre 1966, e lo stesso mese andai e tornai dell’Italia, legalmente, con un un permesso di lavoro emesso da Chamberlain ed ebbi una “Alien Registration Card”, che si usa per gli immigrati. Quindi da quel momento fui ufficialmente residente a Londra, e lavoravo a Ecclestone Street, a due isolati di distanza dalla casa di Tony Banks [il tastierista dei Genesis]. Da non crederci, vero? Tutte queste coincidenze incredibili che continuano a tornare…
Non è ovvio il fatto che tu facessi il progettista di sistemi per il parcheggio e di colpo sia diventato uno scrittore e fotografo rock. Come è successo?
Durante il servizio militare in Italia avevo fatto amicizia con un tizio che come me era pazzo per la musica rock. Si chiamava Giuseppe Della Valle ed era di Vercelli. Gail mi mandava Melody Maker e Record Mirror ogni settimana, e la domenica sera uscivamo per fare le guardie volontarie. Eravamo di stanza al confine con la Yugoslavia, e in qualche modo Radio Louxemburg, che era una radio pirata inglese, arrivava con un segnale chiarissimo, e ogni domenica sera era come essere in paradiso perché potevamo ascoltare la classifica dei Top 40. Eravamo in mezzo a montagne boscose e in teoria dovevamo fare la guardia alle postazioni anticarro equipaggiate con cannoni da 110 mm puntate verso il confine Yugoslavo, ma tutto ciò che facevamo era mettere la mia radiolina portatile al massimo verso il cielo e ascoltare “I Want To Hold Your Hand” dei Beatles e “Needle And Pins” dei Searchers, che nel gennaio 1966 si contendevano la prima posizione. Facevamo falò, ci arrostivamo le patate e bevevamo grappa mentre venivamo iniziati al rock and roll! Così quando andai in Inghilterra spedivo album e altre cose a Della Valle, e in questi pacchetti mettevo i dischi e gli scrivevo quali fossero le nuove band sulla scena.

Tony Abbro, newsagent, Old Compton Street, December 1960. Photograph: John Deakin. Copyright 2014 John Deakin Archive
Dopo nove mesi che stavo a Londra, trovai una rivista chiamata “BIG” in un’edicola di Old Compton Street. Era la rivista di musica rock che ero solito comprare in Italia. All’epoca c’erano “Ciao Amici” e “BIG”, e la seconda era fantastica, di grande formato e piegata, come Rolling Stone all’epoca. Avevano grandi autori come Fabrizio Zampa, Paola Dessy e Piero Vivarelli, che scrisse “24 mila baci” per Celentano. Ero così felice, perché essere in Inghilterra a quei tempi era come stare sulla luna, sai?, era davvero distante come un altro pianeta Quindi scrissi una lettera all’editore della rivista: “Vi ho trovati a Londra, fantastico!, ma le classifiche inglesi che pubblicate sono indietro di tre mesi, se volete posso mandarvele ogni settimana…”
Un mattino ricevo un telegramma: “Chiamaci, a nostro carico. Sergio Modugno.” Era il caporedattore, o qualcosa del genere. Come ogni mattina stavo andando al lavoro da East Croydon alla stazione Victoria, aprii il giornale e indovina cosa vidi? “Il fenomeno pop italiano Rita Pavone è a Londra.” Rita Pavone era diciannovesima in classifica con “Heart”, la versione inglese di “Cuore” che aveva venduto un milione di copie in Italia, ed era a Londra per partecipare a “Top of the Pops”. Quindi chiamai la rivista, parlai con Sergio e gli dissi: “Rita Pavone è qui, vuoi un articolo?”
“Assolutamente sì… ma che studi hai fatto?”
“Sono un geometra.”
“Ma sai scrivere?” (Ride)
Risposi di sì senza esitazione, e in qualche modo ero tranquillo dal momento che avevo sempre amato scrivere da quando un mio insegnante, Quintiliano Marino, aveva letto uno dei miei primi temi davanti alla classe. Avevo anche passato tutto il servizio militare scrivendo centinaia di lettere d’amore alla mia ragazza inglese.
“Intervista Rita Pavone, salutacela perché è una nostra amica, fai qualche foto e mandaci tutto.”
E riattaccò.
Questo accadeva alle dieci del mattino. La casa discografica di Rita Pavone era la RCA, così li chiamai: “Sono un giornalista italiano…” e mi diedero il numero di telefono del suo agente stampa, un tizio simpatico che chiudeva qualsiasi frase con la parola ‘love’. Lo chiamai e mi richiamò immediatamente: “vieni alle due oggi pomeriggio, love!”, spiegandomi in quale hotel avrei incontrato Rita, in Conduit Street, vicino a Bond Street. Misi giù il telefono e dissi a Mr. Fairgrieve che non mi sentivo per niente bene, avevo la nausea e dovevo andare a casa. Quindi corsi a casa a Croydon, presi in prestito la macchina fotografica della madre della mia ragazza, mi feci spiegare come usarla… tolsi la custodia, tornai a Londra, preparai le domande e andai in questo hotel a cinque stelle. Alle due in punto bussai alla porta. E venne ad aprire Teddy Reno! Teddy Reno era un cantante molto noto che aveva scoperto questa quindicenne che cantava come un usignolo, ed era diventato il suo manager. Solo che a un certo punto… insomma, c’era stato un grosso scandalo in Italia perché lei era minorenne e a quanto pareva avevano avuto una storia. Il padre di Rita era andato in orbita e quindi dovettero lasciarsi. E io ora li avevo trovati assieme a Londra: grosso scoop! Prima ancora di sapere cosa fosse uno scoop! (Ride.)
Feci la mia intervista e le chiesi di scendere in strada a fare qualche foto, per far vedere che era davvero a Londra. Mi rispose con entusiasmo: “oh, sì, naturalmente!” “Copriti bene, devi cantare stasera!” disse Teddy Reno mentre scendevamo. Aspettai che passasse un autobus in modo da averlo sullo sfondo, inquadrai anche uno dei pilastri delle tipiche cassette delle lettere inglesi, feci le mie foto… e la salutai. Non ho idea del perché non andai a “Top Of The Pops” con lei, ma avevo la mia intervista e le foto. Il mio primo scoop!
A quel punto non sapevo bene cosa fare. Nei film che avevo visto, i giornalisti andavano al bar, si fumavano una sigaretta, bevevano un caffè e scrivevano: così lo feci anch’io! Finii in una caffetteria dalle parti di Soho Square e scrissi l’articolo, a mano. Lo finii quando probabilmente erano le sei o le sette di sera, misi la pellicola ancora da sviluppare nella busta (una cosa da non fare mai!), andai a Trafalgar Square perché sapevo che l’ufficio postale era aperto 24 ore al giorno e spedii tutto a Roma all’indirizzo di “BIG”.
Più o meno un mese dopo… mi arrivò la rivista con un articolo a doppia pagina: “RITA PAVONE A LONDRA: Per qualche sterlina in più. Dal nostro corrispondente Armando Gallo”. Forse era un gioco di parole con il titolo, famosissimo, di Sergio Leone: “Per qualche dollaro in più”… C’erano due foto fatte da me con Rita Pavone che salutava da Londra!
Avevano allegato una lettera con una domanda: “Dove ti mandiamo il pagamento? Ai tuoi genitori in Italia o direttamente a te a Londra?” Ero così in gas che pensai: “Gesù, e mi pagano pure per questo?”
… e io che feci? Me ne andai dritto a Manchester Square alla EMI, la casa discografica dei Beatles, mi avvicinai alla receptionist, una signora anziana e sorridente e dissi: “Sono un giornalista italiano. Vorrei intervistare i Beatles.“ (Ride) La mia carriera di giornalista iniziò così.
Li hai poi intervistati?

No. I Beatles avevano smesso di concedere interviste in quel periodo. Erano scomparsi per mesi e stavano mettendo insieme un nuovo album che sarebbe diventato “Sgt. Pepper”. Stiamo parlando del marzo 1967. In quel periodo feci i Troggs, che finirono al #1 con “Wild Thing” ed erano rappresentati dallo stesso addetto stampa “ciao, love” che mi aveva procurato l’intervista con Rita Pavone. Lui rappresentava anche Sandie Shaw che aveva vinto l’Eurovision Song Contest con “Puppet On A String”, e la intervistai allo studio radiofonico della BBC che era nei pressi di Piccadilly Circus. Ornella Vanoni era lì e le chiesi di posare per una foto, ma non mi trattà molto bene quando si accorse che avevo la modesta fotocamera della madre della mia ragazza. Fu una delusione, ma quando arrivò Sandie Shaw e la fotografai assieme ad alcuni altri fotografi, Ornella Vanoni si mise in posa per me dietro di lei. Ma io non scattai quella foto: probabilmente la rivista l’avrebbe usata, ma non la feci proprio, e fu finita lì! Questo tipo di comportamento lo ho visto molte volte con artisti italiani all’estero che darebbero qualsiasi cosa per mettersi in posa vicino a una star internazionale.
Nel frattempo facevo la posta a Manchester Square e a Jim Watson, che alla EMI era colui che si occupava del settore internazionale: io volevo i Beatles! Invece lui continuava a presentarmi a questi nuovi gruppi totalmente sconosciuti, come un complesso che aveva appena pubblicato un singolo intitolato “Arnold Layne” [si trattava dei Pink Floyd.]
Il loro produttore era Norman Smith, che era stato il primo tecnico del suono dei Beatles. Sempre Jim mi presentò The Creation e The Koobas, due gruppi EMI che erano diventati famosi in Germania e in Danimarca, e che forse – pensava – avrebbero potuto avere qualche chance in Italia. Il loro manager era Tony Stratton-Smith, una persona gradevole e felice che amava bere e scommettere sui cavalli. Jim e Strat non conoscevano alcun giornalista italiano: è incredibile, ma ti dà un’idea di quanto distante fosse Londra… nella primavera del 1967, la EMI International non aveva alcun contatto con la stampa italiana, a Londra. Jim mi portava a vedere nuovi gruppi nei pub e nei club. Era un tipo simpatico, mi pagava da bere, ma “BIG” non voleva gruppi sconosciuti – voleva i Beatles…
E poi, un pomeriggio mi chiamò in ufficio. Jim sapeva che lavoravo durante il giorno, quindi mi invitava ai concerti alla sera. Ma la sua telefonata aveva un tono vagamente urgente: “Puoi uscire?” Uscii, e corsi a Manchester Square, dove mi aspettava e mi portò a Belgravia. E lì c’era questa pazzia in corso… i maledetti Beatles erano lì, fuori dalla casa di Brian Epstein, il loro manager, e tutti che gli scattavano foto sui gradini di questa casa Edwardiana. Io non avevo una macchina fotografica, non avevo nulla. Ci portarono al piano di sopra, dove “Sgt. Pepper” suonava a ripetizione. Tutti i DJ della televisione inglese erano nella stanza: Alan Freeman, Jimmy Seville, David Jacobs… e i Beatles! Non ero mai stato in una stanza così piena di celebrità, e i Beatles erano questi tizi piccolini… non assomigliavano affatto ai Beatles ai miei occhi. Avevano gli occhiali, i baffi e questi pastrani tipo caffetano… erano diversi, capisci? E io non riuscivo a parlare… ero paralizzato. Avevo ventitré anni, ma ero ancora molto timido, più o meno come un quindicenne oggi. Però scrissi la storia ed ebbi l’album. Mandai la copertina in Italia e la pubblicarono a doppia pagina. Sulla copertina di “BIG” c’era scritto “Anteprima assoluta!”, e il mio pezzo su “Sgt. Pepper” era lungo tre pagine. Lo ho ritrovato grazie a un collezionista, cinque anni fa.
È divertente se ci pensi: una delle canzoni di “Sgt. Pepper” era “Lovely Rita” e parlava di una ragazza parcheggiatrice… quindi il problema dei sistemi di parcheggio era sempre sul tuo orizzonte, eh? Che coincidenza.
Lovely Rita esisteva davvero. C’era una ragazza-parchimetro a Manchester Square, dove c’era il quartier generale della EMI, ti multava se avevi dimenticato di mettere il denaro necessario. Mi dissero che era stata lei a ispirare il personaggio a Paul McCartney, che si era una volta beccato una multa da lei.

Dopo quello sui Beatles feci un articolo sui Procol Harum: Matthew Fisher, il loro organista, viveva a Croydon come me. Era co-autore della linea melodica di “A Whiter Shade Of Pale”. Lo vidi per caso in treno, andando su e giù dalla città, e mi invitò al loro concerto al Saville Theatre, dove aprirono per Jimi Hendrix. Parlai a Jimi Hendrix dopo la prova, quel giorno, e ci feci un articolo. Scrissi anche un articolo intitolato “Musica contro fiori”: a San Francisco erano in pieno Flower Power, e la risposta inglese era la musica psichedelica. Alla fine di quell’articolo presentai questa nuova incredibile band chiamata… Pink Floyd.
Norman Smith, che era il loro produttore ad Abbey Road, aveva anche prodotto “S. F. Sorrow” dei Pretty Things, che era un grande album, ed Herbie Going. Ripensandoci, sì… ebbi una facilità di accesso incredibile, all’epoca, ma non me ne rendevo conto. Ero mosso dalla mia passione per la musica e da questo nuovo ruolo di corrispondente da Londra. Tornai a Roma nel mese di ottobre 1967 con gli Small Faces, P. P. Arnold ed Andrew Oldham che era stato il manager dei Rolling Stones e che all’epoca gestiva l’etichetta discografica Immediate. Più o meno nello stesso periodo mi divisi dalla famiglia Simpson e mi spostai a Chelsea. Mia sorella venne a Londra e finì per fare la babysitter di P. P. Arnold. P. P. era una cantante nera di Los Angeles e quell’estate arrivò al #1 con il brano “The First Cut Is The Deepest”, una canzone di Cat Stevens. Voleva trasferirsi in Inghilterra, quindi tornò a Los Angeles a recuperare i suoi due figli e aveva bisogno di una babysitter. P. P. Arnold aveva un gruppo di accompagnamento chiamato The Nice! Quando tornò in America, il gruppo suonò stabilmente al famoso Speakeasy club, come formazione strumentale, e il tastierista era Keith Emerson, come ben sai. Fu allora che Tony Stratton-Smith li mise sotto contratto. Era un periodo incredibile. Londra, alla fine degli anni ’60, era in ebollizione, ma perfino con cose come “Sgt. Pepper”, i Beatles e roba del genere… rimaneva un luogo molto piccolo. Gli artisti che finivano al #1 non erano milionari: ricordo che gli Small Faces registrarono un album di successo, e io scrissi la versione italiana del testo di una canzone intitolata “Green Circles”. Era Ronnie Lane, il bassista, a cantare – non Steve Marriott, e andai a trovarlo nel piccolo appartamento nel quale viveva a per insegnargli la pronuncia. Mi sembravano rock star, ma lui viveva in un posto minuscolo sopra un negozio di liquori a Earl’s Court, e io stavo lì a insegnargli il testo in italiano di questa canzone che registrammo una notte agli Olympic Studios, e venne Brian Jones a farci visita. In ogni caso, questo è ciò che accadde nel mio primo periodo come giornalista.
[La seconda parte di questo articolo si trova qui.]


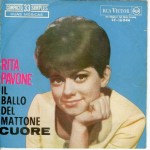
This guy is so fucking lucky! Grazie Marco!. L’ho letta d’un fiato; troppo bella.
Grazie di cuore a te, Armando!