Ritorno a scrivere un articolo un anno quasi esatto dopo l’ultimo. Qualcuno si sarà chiesto dove fossi finito e perché io sia passato repentinamente al silenzio: nessun motivo particolare; semplicemente non mi sono sentito motivato a scrivere molto, avendo anche la sensazione di avere scritto fin troppo in passato. Quindi, ho fatto una deviazione e sono andato ad ammirare panorami diversi. Non scrivo per vendere qualcosa, né per esibirmi: scrivo se ho qualcosa che penso valga la pena scrivere – e in questi giorni il pensiero mi è venuto. Quindi, eccomi.
Questo articolo non ha alcuna pretesa di verità: esprimo solo un’idea che si sta formando e che è rispettabile né più, né meno di qualsiasi altra idea. L’articolo nasce da una lunga ed estenuante discussione avvenuta sulla mia pagina Facebook a proposito di un’immagine da me condivisa. Si trattava di una “fotografia” (il perché delle virgolette lo spiegherò a breve) tratta da una campagna pubblicitaria per un plug-in HDR. A mio modo di vedere, la post-produzione era ridicolmente spinta: ma su questo non discuto, è gusto personale. Mi dava però assai fastidio il fatto che questa immagine venisse sostanzialmente proposta come modello di ciò che si può ottenere con questo plug-in, in modo che le fotografie “escano” dalla pagina più delle altre. Come se una fotografia dovesse per forza “uscire”, per essere buona; o addirittura per essere bella – che è un attributo diverso da buona. Per questo affermavo lapidariamente: “questa non è una fotografia”, sapendo benissimo che avrei suscitato un vespaio.
Come previsto, si sono aperte le acque del Mar Rosso, creando tre schieramenti contrapposti di tendenze praticamente inconciliabili. Le tre scuole di pensiero si possono riassumere in queste linee essenziali:
- Niente è fotografia.
- È fotografia solo ciò che arriva fino a un certo limite, oltre no.
- Tutto è fotografia.
Piuttosto che reiterare una discussione vecchia come il mondo, provo a lanciare una provocazione e vi propongo una “fotografia”, qui sotto.
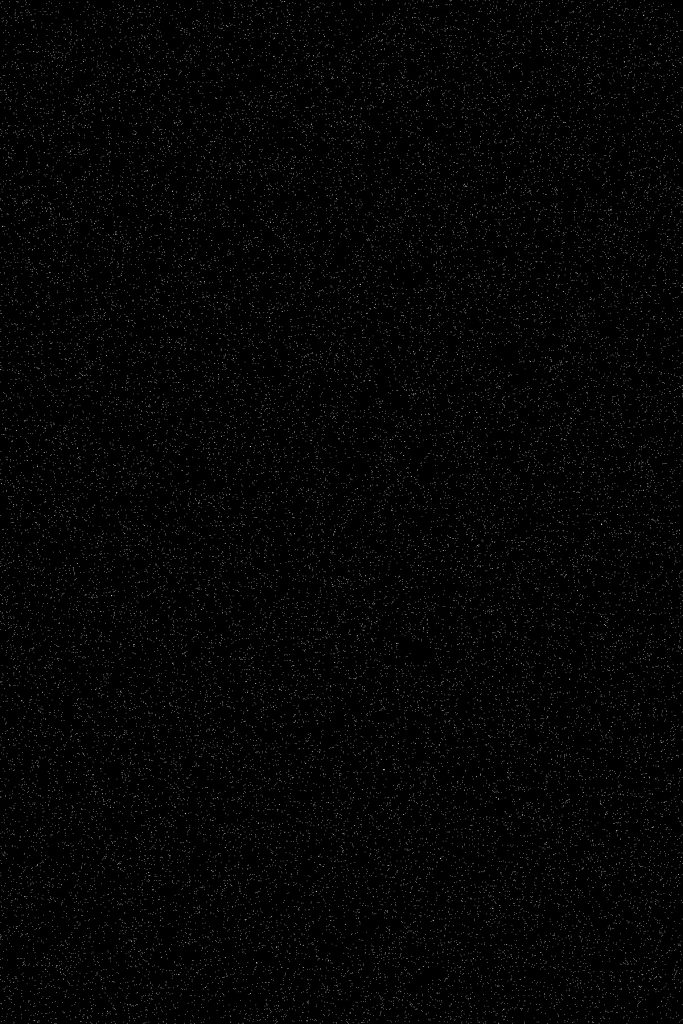
Vi spiego come l’ho ottenuta. Sono partito da una fotografia normalissima, incollandola sopra uno sfondo bianco; ho impostato il metodo di fusione su Dissolvi, Opacità 1%; ho unito i livelli in un composito applicando la curva di contrasto più ripida che Photoshop consente di realizzare; ho invertito il livello.
Questa immagine, che ho battezzato “TCT” è del tutto concettuale, perché non riproduce nulla di riconoscibile, credo, per nessuno.
Ora vi mostro l’originale.

“TCT” sta per “The Crumbling Tower”, ovvero “La torre che si sbriciola”. Questa fotografia è banale a dir poco: semplice istantanea turistica di nessun pregio. È probabilmente la cosa meno manipolata che si possa ottenere da Camera Raw: ho aperto il file, tutto a zero, temperatura colore come scattato, profilo di fotocamera Camera Neutral – fine. Non c’è nessuna post-produzione, a meno che non consideriamo post-produzione anche il mero sviluppo effettuato secondo i predefiniti proposti da Adobe. A margine, non l’ho neppure ritagliata.
Che parentela esiste tra l’originale e la mia provocatoria versione? Una parentela fortissima – oppure nessuna: dipende dai punti di vista. Fortissima, se vogliamo affermare (ed è vero) che “TCT” è a tutti gli effetti questa immagine, manipolata in maniera brutale ma con manovre semplicissime. Nessuna, se vogliamo affermare che in “TCT” non si riconosce alcuna torre, tantomeno quella di Pisa. Io personalmente propendo per la seconda risposta: posso pensare che esistano tre persone nella popolazione mondiale che s’innamorerebbero di “TCT” in quanto opera d’arte astratta e concettuale, e credo che potrei scrivere una presentazione altisonante per essa, dichiarando che esprime il lacerante dolore per lo sgretolamento del reale, filtrato dall’io bambino che ancora vorrebbe vedere un simbolo ergersi fallico dalla terra madre – e via dicendo: cambiate le parole a piacere, sono giustificazioni a posteriori e non contano nulla. Ma detto questo, il problema insormontabile che ho con la seconda versione è che non riconosco il soggetto. Non ho un problema con questo fatto in sé: ieri raccontavo a qualcuno che in casa ho una stampa di grande formato regalatami da un amico, e la adoro. Rappresenta una massa colorata costellata di puntini e strutture, con un’armonica curva a definirne la geometria. Ed è una fotografia, realizzata credo in pellicola. Ma che io sia dannato se so cosa rappresenta: non m’importa, assolutamente – la trovo bella e tanto mi basta. Il problema che ho è che faccio fatica a definire “TCT” una “fotografia”, perché la psiche e l’arte del post-produttore (ahem, sarei io in questo caso) sono talmente presenti e invadenti che offuscano il soggetto originale. “TCT”, al di là del fatto che fa schifo, è un’immagine digitale – per me; non una fotografia.
Potremmo spingere il concetto ancora più in là. Prendiamo l’originale che ritrae la Torre di Pisa, selezioniamo solo il pixel più in alto a sinistra e cancelliamo tutti gli altri. Ci rimane un documento che contiene un pixel di origine fotografica mentre tutto il resto è trasparente. Non esiste più alcuna torre. A quel punto, dipingiamo su un livello ciò che vogliamo. Salviamo. Questa è la nostra opera d’arte, lecita. La chiameremo A.
Ora scenario alternativo: riavvolgiamo il nastro e partiamo da un documento delle stesse dimensioni, vuoto. Dipingiamo a mano un pixel in alto a sinistra. Forziamo il destino: ammettiamo che le coordinate RGB siano per caso identiche a quelle dell’unico pixel che avevamo salvato – e stiamo ipotizzando di non avere mai visto la foto. Poi dipingiamo su un livello ciò che vogliamo, esattamente come prima. Salviamo. Questa è la nostra opera d’arte, lecita. La chiameremo B.
Una scuola che considero sinceramente sofistica direbbe che le due opere sono diverse, perché diversa è la natura del pixel di partenza. Il primo nasce da una fotografia: la versione A deriva da una manipolazione estrema e distruttiva, ma pur sempre su base fotografica. La versione B invece no, nasce da zero: quindi è digital art. Credo che comprendiate dove si annidi il problema. Tutto questo, naturalmente, a prescindere dal fatto che in condizioni normali un solo pixel non si nota pressoché mai, se pensiamo di osservare un’opera nel suo complesso.
Il problema nel definire “fotografia” è che non ci metteremo mai d’accordo su una formula che possa valere sempre e per tutti. La fotografia non riproduce fedelmente la realtà, al massimo la imita e in generale ha solo la pretesa di farlo – e fallisce. Il fotografo, con il suo famoso “occhio”, ci mette del suo. In aggiunta, non possiamo assimilare la fotografia alla visione umana, per ovvie differenze di processo. In aggiunta ancora, se anche questo fosse possibile, basterebbe un tempo di esposizione di 1s su una scena in movimento per riprodurre un mosso artistico che non ha alcun paragone nella realtà – non potremmo mai vedere con gli occhi una scena simile. E poi il bianco e nero, che è astrazione; e poi i viraggi, che sono appena meno astratti ma comunque artificiosi, e via dicendo. Non se ne esce.
Il problema vero a mio parere è che spesso rischiamo di confondere una prassi, quella fotografica, ampissima e variegata, con la linguistica. Cadere in contraddizioni linguistiche è un attimo. Dal mio punto di vista, affermare che una fotografia digitale non è una vera fotografia perché solo l’analogico bla bla bla, è come affermare che dovremmo cambiare il nome a una disciplina chiamata “geometria” solo perché si è sviluppata oltre la semplice agrimensura, la misura della terra – pratica da cui è nata. Allo stesso tempo, affermare che una stampa a getto d’inchiostro non è una fotografia perché il processo che la produce non coinvolge direttamente un’impressione luminosa, a differenza di ciò che accadeva nella stampa tradizionale, è perlomeno discutibile. Il nodo sta nell’interpretazione del termine: vogliamo che sia puntuale e rigido o vogliamo che definisca una classe di processi, non necessariamente foto-grafici (il trattino pone l’accento su foto-, ovvero “luce”)? Non è semplice. Un render 3D non è una fotografia, ma in certi casi è quasi impossibile distinguerlo da una foto vera. Osserviamo l’esempio qui sotto:

Una delle due immagini è la fotografia a cui ci si è ispirati per il render; l’altra è il render risultante. Sono naturalmente diverse: ma quale ritrae la realtà e quale invece è generata da modelli matematici? Non lo rivelerò, ma ho la sensazione che se chiedessimo una risposta a un centinaio di persone scelte a caso, la divisione si assesterebbe su 50/50 circa: ovvero, in condizioni normali non si è in grado di stabilire una differenza. Ho in mente un gruppo di persone che, osservando il render, direbbe d’istinto “questa non è una fotografia ma un’immagine sintetica”, ma per farlo con certezza servono un’esperienza e un’abitudine alle immagini di gran lunga superiori a quelle che in media s’incontrano “per strada”. Alla fine, dobbiamo accettare che la maggior parte delle persone che guardano una fotografia non si rapporta a essa in maniera tecnica, ma emotiva. Quindi ogni discussione tecnica è, per definizione, di nicchia – se non di casta.
A monte, io credo che ci sia un problema che non riguarda solo le fotografie. Riguarda quelle che si chiamano categorie. Le categorie sono lo strumento con cui inconsciamente, cerchiamo di ordinare e dare un senso al mondo che ci circonda. Una categoria non è un astruso concetto filosofico, ma una cosa molto semplice: è l’unione di un soggetto con un predicato. Se affermo “la mela è gialla” unisco il soggetto mela con il predicato è gialla. Così facendo creo immediatamente due scatole ideali: una che contiene solo mele gialle, una che contiene non solo le mele di un altro colore, ma anche le non-mele: le pere, gli struzzi, le astronavi, insomma tutto il resto. Il risultato è che ho separato, se volete ho ordinato, le mele gialle rispetto al resto. Fantastico, no?
Possono esserci categorie assai più complesse: le mele di un certo tipo e di un certo colore; le mele di un certo tipo, di un certo colore, il cui diametro massimo non sia inferiore a tot centimetri; e via dicendo. Ma alla fine ci ritroviamo con: scatole, scatole, scatole. O se preferiamo: cassetti, cassetti, cassetti.
Il grande errore è pensare che i cassetti siano a tenuta stagna e nulla possa filtrare da un cassetto all’altro: eppure, per salvare un ordine che probabilmente non esiste, questo è ciò che facciamo. A questo proposito c’è una storia emblematica, esposta in maniera mirabile da Robert Pirsig, recentemente scomparso, nel suo romanzo “Lila: un’indagine sulla morale”. La storia affronta il problema di quanto limitate e potenzialmente dannose siano le categorie e coinvolge un animale chiamato ornitorinco.
La zoologia ha sempre diviso i mammiferi dai rettili in base a uno schema semplice: i mammiferi allattano i piccoli, i rettili depongono le uova. Come categorie, i due cassetti “mammiferi” e “rettili” sono meravigliosi, in apparenza, perché nessun mammifero depone le uova, e nessun rettile allatta i piccoli. Pertanto, si tratta di due cassetti grandi, con contenuti multiformi, ma perfettamente stagni. In apparenza.
L’ornitorinco è un animale perlomeno strano, ma non venne scoperto fino alla fine del 1700 perché viveva in Australia. Lo studiò per primo uno zoologo britannico, e ciò che scoprì causò un notevole fermento nel mondo scientifico: l’animale deponeva le uova come un rettile, ma allattava i suoi piccoli. Un mistero, una meraviglia, un mostro: un paradosso, insomma.
L’ornitorinco è un paradosso perché appartiene a entrambe le categorie dei mammiferi e dei rettili, e così facendo mette in serissima crisi un ordine apparentemente inattaccabile. Come può esistere un paradosso simile? Mostro!
La risposta è che quel paradosso non esiste. Pirsig osserva che gli ornitorinchi hanno deposto uova e allattato i piccoli per qualche milione di anni prima che gli zoologi dichiarassero “illegale” il suo comportamento. Illegale, naturalmente, in base a categorie che funzionavano benissimo, ma erano troppo rigide.
“L’unico mistero è come osservatori scientifici maturi, obiettivi e di esperienza possano attribuire il loro scivolone a un povero ornitorinco”
commenta lapidario Pirsig. E ha ragione. Non capiamo quasi nulla della natura di molte cose: il libero arbitrio, il dualismo onda-particella, il rapporto della mente con il corpo, cosa accada alla realtà quando ci avviciniamo alla lunghezza di Planck, al di sotto della quale si ipotizza che i concetti stessi di spazio e tempo perdano di senso. La lista è lunghissima.
Sottovoce, inserirei anche il termine “fotografia” tra quelli per cui la categorizzazione crolla miseramente. Dal momento che non riusciamo a darne una classificazione precisa, sembra che l’unica possibilità per salvarci in corner sia affermare che qualcosa non funziona in certe sue manifestazioni. E io sono il primo colpevole, beninteso. Ma questo non va bene: avrebbe assai più senso cercare di andare oltre.
Mi fermo qui, per ora, ma vorrei riprendere il discorso, perché un’idea di qualche genere ce l’ho: senza pretendere che sia “vera”. Anche perché “essere vero” è, di nuovo, un predicato che porta allo sfacelo – tutto il resto è per definizione non-vero, quindi falso. E si apre, ahimè, la strada dell’integralismo.
Ora la cosa più probabile è che qualcuno mi proponga la fotografia di un ornitorinco e mi chieda cosa ne penso. Risposta anticipata: che la nostra estinzione potrebbe non essere un gran male – se quello sarà davvero il caso.
Prometto di riscrivere presto. Ovvero: non-tardi.
MO


MARCO LA PRIMA IMMAGINE LA VEDO NERA COMPLETAMENTE. SONO CURIOSO PERCHE’ IL TUO è UN ARTICOLO ESTREMAMENTE INTERESSANTE.
ROBERTO
Grazie di avere fatto questo commento. È perfetto per ciò che ho cercato di dire. Io e Roberto non ci siamo messi d’accordo prima, sia chiaro.
MO
Bell’articolo stimolante! Probabilmente non ci sono cassetti a tenuta stagna come dici tu nell’articolo e forse un pò di confusione deriva dal fatto che con lo stesso nome indichiamo due cose diverse. Da una parte abbiamo la “foto-grafia”, cioè un processo che fissa una immagine “reale” su un supporto (sensore, pellicola ecc), dall’altra abbiamo la “fotografia” che si riferisce a un prodotto, una immagine stampata o a video ecc . Per creare un quadro iperrealistico a volte ci si serve di fotografie (punto di partenza) ma rimane un quadro (arrivo). Così succede in un render, magari si parte da una fotografia ma il risultato è un render digitale che non si può chiamare fotografia! Ma come hai sottolineato tu, a volte i confini sono veramente labili… difficili da capire e comprendere. A volte sono le definizioni “vecchie” che ci incastrano in cassetti “piccoli” ….
Grazie del commento, Andrea. Toglierei “vecchie” all’ultima frase, anche se in realtà una qualche grammatica serve per costruire un linguaggio comprensibile. Non è una questione facile, temo.
MO
Bell’articolo. Me lo sono letto tutto d’un fiato e subito mi sono venuti in mente tantissimi altri casi in cui non si riesce a dare delle definizioni attraverso le quali sia possibile catalogare in modo univoco gli oggetti reali; figuriamoci le varie forme d’arte.
La pittura ha fatto e continua a fare scuola su questo argomento con le sue infinite correnti e stili. La stessa scena dipinta da un realista, da un cubista o da un impressionista darà luogo a tre dipinti totalmente diversi. Anche se i 3 pittori avessero a disposizione la stessa tela, gli stesi tubi di colore e gli stessi pennelli.
Anche la fotografia, a mio avviso, deve essere considerata a tutti gli effetti una forma di arte essendo un’interpretazione soggettiva di una scena reale.
Dov’è il confine tra foto reale o foto sintetica (digitale) o tra foto naturale o con post produzione?
Una scena ripresa con una pellicola e stampata su carta fotografica è necessariamente reale e naturale? Al contrario l’utilizzo di una macchina digitale e la stampa a getto d’inchiostro o anche la semplice visione su uno schermo di un computer è necessariamente sintetica e post prodotta?
Su questi argomenti si scatenano, un giorno si, e quello dopo pure, bagarre infinite sui social mentre e all’interno di circoli fotografici, a volte, si arriva fin quasi alle mani.
Penso e credo fermamente che un fotoamatore (oggi sono tutti ph ma io sono affezionato a questo termine) si dovrebbe sentir realizzato quando l’immagine che ottiene con il mezzo e sul supporto che desidera rispecchia esattamente quello che ha visto nel momento in cui ha deciso di fare quella ripresa.
Ed è proprio questa diversa visione e interpretazione che fanno della fotografia una forma d’arte al pari di tutte le altre.
L’integralismo è sicuramente l’atteggiamento più pericoloso che si possa avere, e non solo in questo caso.
Grazie Riccardo. In passato ho visto un po’ di tutto, collaborando con diversi fotografi. Ho imparato che non esiste una visione perfetta e assoluta, unica – e per fortuna. Poi ognuno ha la sua, anche perché è un dato oggettivo che lo still life abbia esigenze diverse dalla fotografia sportiva e dalla macrofotografia – per nominare tre campi a caso. E sì, l’integralismo è subdolo, perché (categorie, di nuovo!) siamo portati a pensare che la nostra idea sia “giusta”. Accettare che esistono altri punti di vista, anche se non ci corrispondono, sarebbe già un grande passo.
Il problema non è cosa sia fotografia e se sia frutto di post produzione più o meno esasperata.
Il problema è, ricorrendo a un esempio, che se un sarto di 70 anni fa un certo taglio di camicia ad un cliente sulla base della sua esperienza, non è che poi il commesso del centro commerciale può andare a dire che la camicia si fa più avvitata o che la stoffa deve essere più elastica perché quelle di Armani sono fatte così.
Se andiamo a guardare gli attuali appassionati di fotografia ma anche i nuovi professionisti, scopriamo che la maggior parte viene dal mondo dell’informatica, appassionati di informatica ed elettronica che si sono appassionati alla fotografia dopo essersi appassionati al computer e poi a photoshop.
Non è certo un male ma la differenza sta nel fatto che vengono da mondi dove il codice binario la fa da padrone, dove ci sono regole, formule, tabelle, caselle. Questo li rende rigidi difensori di alcune regole che nessuno ha mai stabilito come indispensabili: la composizione DEVE essere così, l’illuminazione DEVE essere così, il vestito DEVE essere così ecc.
Più volte si è fatto l’esperimento di inserire in un blog, un forum o un gruppo facebook fotografie di professionisti di fama internazionale e si sono letti i commenti più ridicoli. Gente che dava lezioni di inquadratura a Fontana o del manipolatore che non sapeva usare bene photoshop a Lachapelle, senza sapere che una sola delle loro foto aveva fruttato economicamente più di quanto loro potranno spendere in una vita per l’attrezzatura fotografica.
Il punto è che questa marea di fotografi e fotoamatori nei quali rientriamo tutti, non accetta il fatto di non essere un artista.
Seguire le “regole” non ci rende artisti, non seguire le “regole” nemmeno. Si deve capire che la fotografia non è una forma d’arte, la fotografia è comunicazione. La comunicazione è fatta bene se funziona e se raggiunge il suo scopo. L’arte è un’altra cosa… di arte lasciamone parlare i critici d’arte, non gli utenti dei forum.
Scusate eventuali errori ma ho scritto di getto dallo smartphone.
Questo è ampiamente condivisibile, per quanto mi riguarda, e trovo molto lucida la tua posizione. Io insisto sempre sul rapporto tra tecnica e creatività: la tecnica da sola è fredda, la creatività da sola rischia di produrre mostri. Non li produrrà necessariamente, ma il rischio è elevato.
I commenti sui forum non sono molto diversi dalle opinioni sui vaccini: è il delirio di onnipotenza che prende nel momento in cui si confonde una paginetta scritta da chissà chi con un saggio documentato e attendibile, o con una ricerca scientifica. Nei giorni successivi al post che cito in questo articolo ho ricevuto delle critiche nette per la rigidità della mia posizione: non ho alcun bisogno di difendermi, le accetto e le metto da parte – anche perché giudicare senza conoscere neppure il lavoro di una persona mi sembra perlomeno azzardato. Il fatto è che se spostiamo la discussione su un piano quasi metafisico, come certi tentano di fare, ci ritroveremo con sette milioni di proposte nel menu e niente nel nostro piatto – niente da mangiare, intendo. Per cui, non senza ironia, a volte dico – perché non la smettiamo di discutere e andiamo a fare qualche fotografia? Però a quel punto c’è sempre qualcuno che chiede: “ok, ma cosa intendiamo per fotografia?” E così, ad infinitum. È un mondo difficile, lo so.
Grazie Igor,
MO
ciao, ti seguivo su Reflex ed ora ti ho trovato su FotoCult, bene spero che la tua collaborazione continui…io fotografo solo per mio puro divertimento, non ci devo campare (per fortuna) e mi dispiace moltissimo quando leggo certe frasi offensive solo perché c’è qualcuno che non la pensa come te su argomenti legati alla fotografia, (lo stesso mi darebbe fastidio sulla politica anche se purtroppo ci stiamo abituando a questo). L’articolo mi è piaciuto molto perché va a toccare anche argomenti come il diverso e l’integralismo da cui dobbiamo prendere le distanze, grazie.
Grazie a te, Riccardo!
MO
Ciao Marco. Tu non scrivevi da un anno, io ti commento dopo un mese, direi che a livello di delay siamo a posto.
Detto questo, sui forum mi è capitato spessissimo di arrivare a dibattere sul questa è fotografia /questa no, condito da derive epiche sulla legittimità della post produzione.
Alla fine ho capito (abbondando in paradossi ed ironia) che anche arrivando al foro stenopeico qualcuno potrà sempre rivendicare un “il mio foro è più stenopeico del tuo”.
E come l’hai fatto? Mazzetta e puntello o col trapano? E il muro, di che materiale è? E il bianco dell’intonaco, quanto è bianco? Ma poi bianco rispetto a cosa?
Insomma, non se ne esce MAI.
🙂
Mi viene voglia di rubarti la battuta sul foro stenopeico, perché è vero – è esattamente così che si mettono (male) le cose.
Grazie del commento, a presto!
MO
Con tutto ciò che ti ho rubato io negli anni, il minimo che possa fare per ricambiare è regalartela. So che la migliorerai, come tutte le cose che ti passan per le mani.
🙂
Si potrebbe osservare che nessuno cerca di passare da una stanza all’altra attraversando il muro. Chiunque passa per la porta. Perchè la teoria che si possa attraversare il muro viene confutata. Da chi? dalla realtà. Ed una volta che una teoria è confutata, è confutata.
Ma le teorie che funzionano, come “passare attraverso la porta”, sono vere? solo- e sempre- in modo provvisorio. E’ questa asimmetria – scoperta da un grande epistemologo del 900- ineliminabile- che stritola le nostre categorie – nella pretesa di esser assolute.
Eugenio, grazie per la riflessione – molto acuta.
Ci sarebbe molto da dire, fino al punto di tirare in ballo certi fenomeni quantistici noti ormai da un secolo, che dimostrano quanto l’oggettività sia un concetto assai labile. Esperimenti recenti che coinvolgono l’entanglement di particelle quantistiche, inoltre, rinforzano i dubbi sull’oggettività.
L’esempio del muro e della porta è curioso: perché è “vero” (nel senso che dici) alla nostra scala, ma una particella può tranquillamente apparire al di là di un “muro” di potenziale, che equivale a un muro di mattoni, grazie all’effetto tunnel. Ovvero, un fenomeno risulta “possibile” o “impossibile” a causa di diversi fattori: tra questi, la scala che esaminiamo.
Certo, nel nostro campo fotografico tutto questo rimane su un livello molto teorico, ma è comunque una riflessione interessante, da 20:28 della sera :-).
Un caro saluto!
MO